
“Rimasi per qualche tempo seduto, trasecolato, in assoluto silenzio, chiamando a raccolta le mie facoltà attonite. Subito mi venne da pensare che gli orecchi mi avessero ingannato, oppure che Bartleby avesse completamente frainteso quello che volevo. Ripetei la richiesta con quanta chiarezza mi era possibile, ma con altrettanta chiarezza giunse la risposta di prima: “Preferirei di no”.”
(Herman Melville, Bartleby, lo scrivano traduzione di Gianna Lonza, Garzanti, 1994)
Nel leggere Bartleby, lo scrivano, il lettore sensibile si ritrova a dover spartire la sua attenzione tra due percezioni: la prima è legata alla puntualità millimetrica della struttura lessico-semantica del racconto; la seconda afferisce all’emotività sdrucita e profonda che il racconto stesso spirigiona in maniera subdola.
Quando si legge un racconto perfetto, è come se lo scrittore, afferrataci la mano, ci stesse accompagnando, già nolenti e remissivi, per i sentieri da lui pensati, scritti e imposti. Il mal (o ben) capitato lettore avverte l’illusione di aver il controllo della lettura, di procedere a volte spedito e a volte incespicando, secondo la sua volontà, ma in realtà è lo scrittore che lo sta guidando in un’attrazione inevitabile. È un po’ come in quei percorsi a tema horror nei lunapark: all’inizio un prato fiorito sembra rasserenarci poi, l’epifania di un contadino decapitato ci fa vacillare e si procede così, alternatamente, in un contesto che a noi pare casuale e non-voluto ma che, in realtà, è stato studiato a tavolino dall’impresario del lunapark assieme a qualche tecnico meccanico e a un paio d’esperti dell’horror.
Per meglio esplicare l’ambivalenza che percorre il racconto dello scrittore americano, ci avvarremo, in questa sede, della consulenza illuminante di un brevissimo saggio scritto da Julio Cortàzar, dal titolo Alcuni aspetti del racconto.
Scrive lo scrittore argentino: “Un racconto è significativo quando spezza i propri confini con quell’esplosione di energia spirituale che illumina bruscamente qualcosa che va molto oltre il piccolo e talvolta miserabile aneddoto che narra […] L’eccezionalità (ndA “del tema di un racconto”) risiede in una qualità paragonabile a quella della calamita; un buon tema attrae tutto un sistema di rapporti connessi, coagula nell’autore, e più tardi nel lettore, un’immensa quantità di concetti, intravisioni, sentiementi e perfino idee che galleggiavano virtualmente nella sua memoria o nella sua sensibilità”.

Il tema di Bartleby, lo scrivano non ha nulla di straordinario. Il racconto si svolge all’interno di uno studio legale di Wall Street, tra maniche di camicia inzaccherate e scartoffie da ricopiare, ma è proprio questa atmosfera predeterminata a preparare il terreno all’allucinazione scaturita dall’apparizione del personaggio di Bartleby, alla folgorazione immediata che si attua nel momento stesso in cui egli risponde, per la prima volta, alle richieste del suo datore di lavoro, con la ormai proverbiale frase “Preferirei di no”.
Melville rapisce il lettore giocando con competenza sul tema dell’assurdo. Anticipando di circa settant’annni Il processo di Franz Kafka, per primo (salvo smentite) affronta nella narrativa l’illogicità trattandola con coerenza. Ne Il mito di Sisifo, Albert Camus analizza il romanzo dello scrittore praghese, inteso come esempio perfetto dell’espressione dell’assurdo, raccontando una “storiella di tipo barocco”. Sia chiaro che il discorso portato avanti da Camus nella sua opera può essere tranquillamente traslato su Bartleby, lo scrivano. Scrive Camus: “Si sa la storia del pazzo che pescava in un bagno. Un medico, che aveva idee proprie sui trattamenti psichiatrici e gli chiedeva: “se abboccava all’amo”, si sentì rispondere con severità: “Ma no, imbecille! Se è un bagno.””
Il lettore sensibile del racconto di Melville, rimane ienevitabilmente impressionato dal turbamento particolare che ingenera in lui l’inspiegabile inquietudine emanata dalla figura del protagonista: questo copista sciamannato e attonito, tenuto in vita soltanto da “una livida disperazione”, fastidiosamente ostinato nella ripetizione nella sua immotivata formula di rifiuto: “Preferirei di no”.
Melville rapisce il lettore e lo smarrisce nei meandri di una mente disturbata in costante e indifferente sospensione nei confronti dell’esistenza.
“E l’unico modo in cui si possa ottenere quel sequestro momentaneo del lettore è mediante uno stile basato sull’intensità e sulla tensione, uno stile in cui gli elementi fomali ed espressivi si adattino, senza la benché minima concessione, all’indole del tema, gli diano la sua forma visiva e uditiva più penetrante e originale, lo rendano unico, indimenticabile, lo fissino per sempre nel suo tempo e nel suo ambiente e nel suo senso più primordiale. Ciò che chiamo tensione in un racconto è un’intensità che si esercita nel modo in cui l’autore ci avvicina lentamente al narrato. Siamo ancora lungi dal capire quello che accadrà nel racconto, e tuttavia non possiamo sottrarci alla sua atmosfera […] si sente fin da principio che i fatti in sé sono privi di importanza, che tutto sta nelle forze che li hanno scatenati, nella rete sottile che li ha preceduti e che li accompagna” (Julio Cortàzar, Alcuni aspetti del racconto).
Il racconto di Melville è, per questi motivi, un racconto perfetto, appartenente alla ristrettissima cerchia degli exempla “vademenecumenici” per ogni scrittore di racconti.
La perfezione della scrittura melvilliana, quindi, non è immediatamente avvertita prorpio perché il lettore c’è dentro dall’inizio alla fine, è abituato all’andamento ineffabile del racconto. Se ne accorge soltanto alla fine del libro quando, trovandosi a dover conteggiare le perdite e i benefici dell’esperienza appena conclusa, avverte la nitida sensazione di avere empatizzato (anche per sottrazione, in negativo) con i personaggi, di aver compreso la trama e i suoi sgambetti, di aver inteso tutto ciò che c’era da intendere. “Ogni racconto durevole è come il seme in cui sta dormendo l’albero gigantesco. Quell’albero crescerà in noi, farà ombra nella nostra memoria” (Julio Cortàzar, Alcuni aspetti del racconto).
Fin dalla sua pubblicazione nel 1853, la figura trasandata e “incurabilmente perduta” dello scrivano che si rifiuta di scrivere e di obbedire, ha tormentato i critici e riufiutato ogni sorta di spiegazione logica. Quel “preferirei di no” è stampato all’ingresso della letteratura americana come lo era l’enigma della Sfinge alle porte di Tebe. Qual è il senso di questa formula che Bartleby oppone a ogni richiesta? Qual è il messaggio sotteso?

Alfine di non venir miseramente divorati dalla “Sfinge melvilliana”, Gilles Deleuze e Giorgio Agamben hanno provato a risolvere l’enigma in Bartleby. La formula della creazione (Quodlibet, 2011).
Deleuze attribuisce alla frase di Bartleby il carattere di una sospensione tra affermazione e negazione, pronunciata da “un uomo senza referenze, senza possessi, senza proprietà, senza qualità… senza passato né futuro, istantaneo…” in cui si cela l’archetipo del “disadattato moderno”, in perenne fuga da se stesso, dalla società, da tutti.
Giorgio Agamben, invece, muovendo da presupposti più strettamente filosofici, e in particolare da Aristotele, legge nella formula di Bartleby le sfumature del “pensiero che pensa se stesso”. “Non stupisce, quindi, che egli (ndA, “Bartleby”) dimori così ostinatamente nell’abisso della possibilità e non sembri avere la più piccola intenzione di uscirne”. Lo scrivano che “come un autentico spettro obbediente alle leggi dell’evocazione spiritica” non afferma e non nega, non accetta e non rifiuta, esprime, secondo Agamben, “una rinuncia alla Verità, alla Legge, al Giudizio, in una nuova creazione del possibile, in una Palingenesi inverificabile”.
“Lo fissai con aria risoluta. Il volto era smunto nella sua compostezza; gli occhi grigi, fiochi e tranquilli. Non una grinza gli increspava il viso. Se ci fosse stato un sintomo anche minimo di disagio, di rabbia, di insofferenza, di impertinenza, in altre parole se ci fosse stato in lui qualcosa di normalmente umano, lo avrei cacciato con brutalità dal mio ufficio. Ma così come stavano le cose, tanto valeva che decidessi di buttar fuori della porta il pallido busto in gesso di Cicerone. Restai a fissarlo per qualche tempo, mentre continuava a scrivere, quindi mi rimisi alla scrivania”.
(Herman Melville, Bartleby, lo scrivano traduzione di Gianna Lonza, Garzanti, 1994)
Non mancano, tuttavia, a latere di ogni discorso sull’astrazione dell’individuo dalla società e sull’assurdità di un’esistenza inspiegabile, degli accorati appelli alla compassione e alla comprensione umana che Melville affida all’avvocato-datore di lavoro e che porteranno quest’ultimo a una risoluzione del suo rapporto con Bartleby profondamente influenzata dalla carità cristiana.
“Come è vero – e tremendo – che fino a un certo punto il pensiero e lo spettacolo della miseria suscitano i nostri sentimenti migliori, ma che, in certi casi, esiste un limite oltre il quale non è più così. E sbaglia chi sostiene che tutto ciò deriva dall’innato egoismo del cuore umano: no, scaturisce semmai dal senso di impotenza che si può provare di fronte a mali troppo gravi e incurabili. Per un essere sensibile, non di rado la compassione coincide con la sofferenza. E quando si giunge finalmente a comprendere che non è sufficiente la pietà per offrire un valido soccorso, il buonsenso invita l’anima a sbarazzarsene. Ciò che vidi in quel mattino mi convinse che lo scrivano era vittima di qualche male congenito e incurabile. Potevo fare la carità al suo corpo, ma non era il suo corpo a darglio pena: era la sua anima a soffrire, e quella io non la potevo raggiungere”.
(Herman Melville, Bartleby, lo scrivano traduzione di Gianna Lonza, Garzanti, 1994)
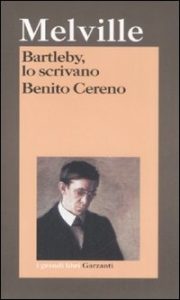
Bartleby, lo scrivano venne scritto da Melville due anni dopo la pubblicazione di Moby Dick. Lo scrittore americano fu incompreso dal pubblico e dalla crititca e morì proprio quando aveva raggiunto la massima maturità espressiva, nell’oblio dei contemporanei. Come il “grande romanzo della balena” venne a posteriori rivalutato e risarcito della sua innegabile importanza, così accade per il racconto di Bartleby, che è oggi considerato tra i più importanti della letteratura americana e uno degli esempi più fulgidamente riusciti del genere del racconto.
A cura di Nazareno Loise
***
“Ora, una domenica mattina, capitandomi di andare alla chiesa della Santissima Trinità per ascoltare un famoso predicatore e trovandomi in zona piuttosto in anticipo, pensai di fare un salto in ufficio. Per fortuna avevo la chiave con me, ma, nell’infilarla nella toppa, mi stupii di non riuscirci perché qualcosa vi si opponeva dall’interno. Alquanto sorpreso, chiamai ad alta voce, quando, con mia costernazione, una chiave girò all’interno e, nella fessura della porta socchiusa, mi trovai di fronte Bartleby che, con il viso smunto, in maniche di camicia e in una tenuta deshabillè stranamente lacera, mi diceva con tutta calma di rammaricarsene, ma in quel momento aveva molto da fare e preferiva non ammettermi. Aggiunse, quindi, poche parole per consigliarmi di fare il giro dell’isolato due o tre volte, perché in capo a quell’intervallo avrebbe probabilmente concluso le sue faccende.
Ora l’apparizione assolutamente inattesa di Bartleby che occupava il mio studio la domenica mattina, con la sua signorile nonchalance cadaverica, ma nello stesso tempo risoluta e controllata, ebbe un tale effetto su di me che di slancio sgattaiolai via dalla mia porta e feci come desiderava. Ma non senza vari fremiti di ribellione impotente contro la mite sfrontatezza di quell’indecifrabile scrivano. Era infatti soprattutto la sua stupefacente docilità che non soltanto mi disarmava, ma, per così dire, mi rendeva impotente. Ritengo, infatti, una sorta di impotenza l’atteggiamento di chi tranquillamente permette al suo impiegato di dargli degli ordini e di mandano via dai suoi locali. Senza contare che mi sentivo molto inquieto: che cosa poteva fare Bartleby nel mio ufficio, in maniche di camicia e per il resto impresentabile, la mattina di una domenica? C’era qualcosa che non quadrava? No, era fuori questione. Neppure per un momento si poteva pensare che Bartleby fosse una persona immorale. Ma che cosa ci faceva lì? Copiare? No, neppure questo; quali che fossero le sue eccentricità, Bartleby era una persona eminentemente decorosa. Sarebbe stato l’ultimo uomo a sedersi alla scrivania in uno stato prossimo alla nudità. Inoltre era domenica, e qualcosa in Bartleby vietava di supporre che potesse trasgredire, con un’occupazione secolare, la dignità della giornata.
Il mio animo, tuttavia, non era tranquillo, e in preda a una irrequieta curiosità, ritornai infine davanti alla porta. Senza difficoltà infilai la chiave ed entrai. Bartleby non si vedeva. Guardai intorno con ansia, sbirciai dietro il suo paravento, ma era chiaro che se ne era andato. Esaminando con attenzione il luogo, conclusi che chissà da quanto tempo Bartleby doveva mangiare, vestirsi, dormire nel mio ufficio; il tutto senza un piatto, senza un letto, senza uno specchio. Il sedile imbottito di un vecchio divano traballante, in un angolo, mostrava la lieve impronta di una forma sparuta che lì si era coricata. Arrotolata sotto la sua scrivania trovai una coperta; sotto la grata vuota del camino, una scatola di lucido e una spazzola; su una sedia, una bacinella di latta con del sapone e un asciugamano cencioso; in un giornale alcune briciole di focaccine e un pezzetto di formaggio. “Sì”, pensai, “è evidente che Bartleby si è installato qui, una sistemazione da scapolo, tutto per conto suo”. Immediatamente mi sentii pervadere dal pensiero: “Che squallida solitudine, che isolamento ci sono qui, sotto i miei occhi! La sua povertà è grande, ma la sua solitudine, che cosa orribile! Pensaci. Alla domenica Wall Street è deserta come Petra; la notte, alla fine di ogni giornata, è il vuoto. Questo edificio, che nei giorni feriali brulica di operosità e di vita, di notte rimanda l’eco del nulla, e durante tutta la domenica è abbandonato. E Bartleby ha scelto questo luogo come propria casa; unico spettatore di una solitudine che ha visto gremita – una specie di novello, innocente Mario, che medita fra le rovine di Cartagine!”.
Per la prima volta in vita mia fui sopraffatto da un senso di ineluttabile, struggente malinconia. Prima di allora non avevo mai sperimentato altro che un triste languore non sgradevole. Il vincolo della comune umanità mi trascinava irresistibilmente verso un cupo sconforto. Una malinconia fraterna! Sì, io e Bartleby eravamo entrambi figli di Adamo. Ricordai le vivide sete e i volti raggianti che avevo visto quel giorno, persone agghindate a festa che, simili a cigni, veleggiavano lungo quel Mississippi che è Broadway; e confrontandoli con il pallido copista, mi dissi: “Ah, la felicità corteggia la luce, ecco perché crediamo che il mondo sia lieto; ma l’infelicità si nasconde e si isola, ecco perché crediamo che non ci sia infelicità”. Queste tristi fantasticherie – senz’altro chimere di un cervello malato e sciocco – condussero ad altri pensieri, più circostanziati, sulle eccentricità di Bartleby. Aleggiava intorno a me il presentimento di qualche strana scoperta. Mi parve di vedere la pallida forma dello scrivano, avvolta in un sudario gelido, giacere fra gente sconosciuta, incurante.
All’improvviso fui attratto dalla scrivania chiusa di Bartleby, con la chiave in bella mostra nella toppa.
“Non voglio fare nulla di male, non intendo soddisfare una crudele curiosità”, pensavo. “La scrivania, inoltre, è di mia proprietà e anche quello che contiene. Così prenderò il coraggio di guardare dentro”. Tutto era disposto in ordine metodico; i fogli in pile regolari. Gli scomparti erano profondi e, spostando i fascicoli delle pratiche, tastai fino in fondo. Dopo un poco toccai qualcosa e la trassi fuori. Era un vecchio fazzoletto di cotone, pesante e annodato. Aprendolo vidi che era il suo salvadanaio.
Mi sovvenni allora dei sommessi misteri che avevo notato in quell’uomo. Rammentai di non averlo mai sentito parlare se non per rispondere; di non averlo mai visto leggere – no, neppure un giornale – sebbene di tanto in tanto avesse abbastanza tempo per sé; ricordai che per lunghi intervalli se ne stava in piedi accanto alla sua pallida finestra dietro il paravento a guardare fuori il muro cieco di mattoni; ero sicuro che non andasse mai a una mensa o a una trattoria, mentre il suo volto esangue indicava chiaramente che non beveva mai birra, come faceva Tacchino, e neppure tè o perfino caffè, come gli altri esseri umani; che non andava mai in alcun posto particolare di mia conoscenza; che non usciva mai a fare una passeggiata, a meno che non ci fosse andato in quel momento; che aveva sempre evitato di dirmi chi fosse, da dove venisse, se avesse parenti al mondo; che, seppure così scarno ed emaciato, non si lamentava mai di star male. E soprattutto rammentavo una certa aria inconsapevole di pallido – come chiamarlo? – pallido sussiego, anzi un alone di austero riserbo, che mi aveva intimorito fino a ridurmi a quella docile accettazione delle sue eccentricità, quando avevo ormai paura di chiedergli di rendermi il più insignificante servizio, sebbene potessi capire, dalla protratta immobilità, che dietro il paravento se ne stava probabilmente in piedi, perso in una di quelle sue fantasticherie trasognate davanti al muro cieco”.
(Herman Melville, Bartleby, lo scrivano traduzione di Gianna Lonza, Garzanti, 1994)




